Quel Natale di una volta
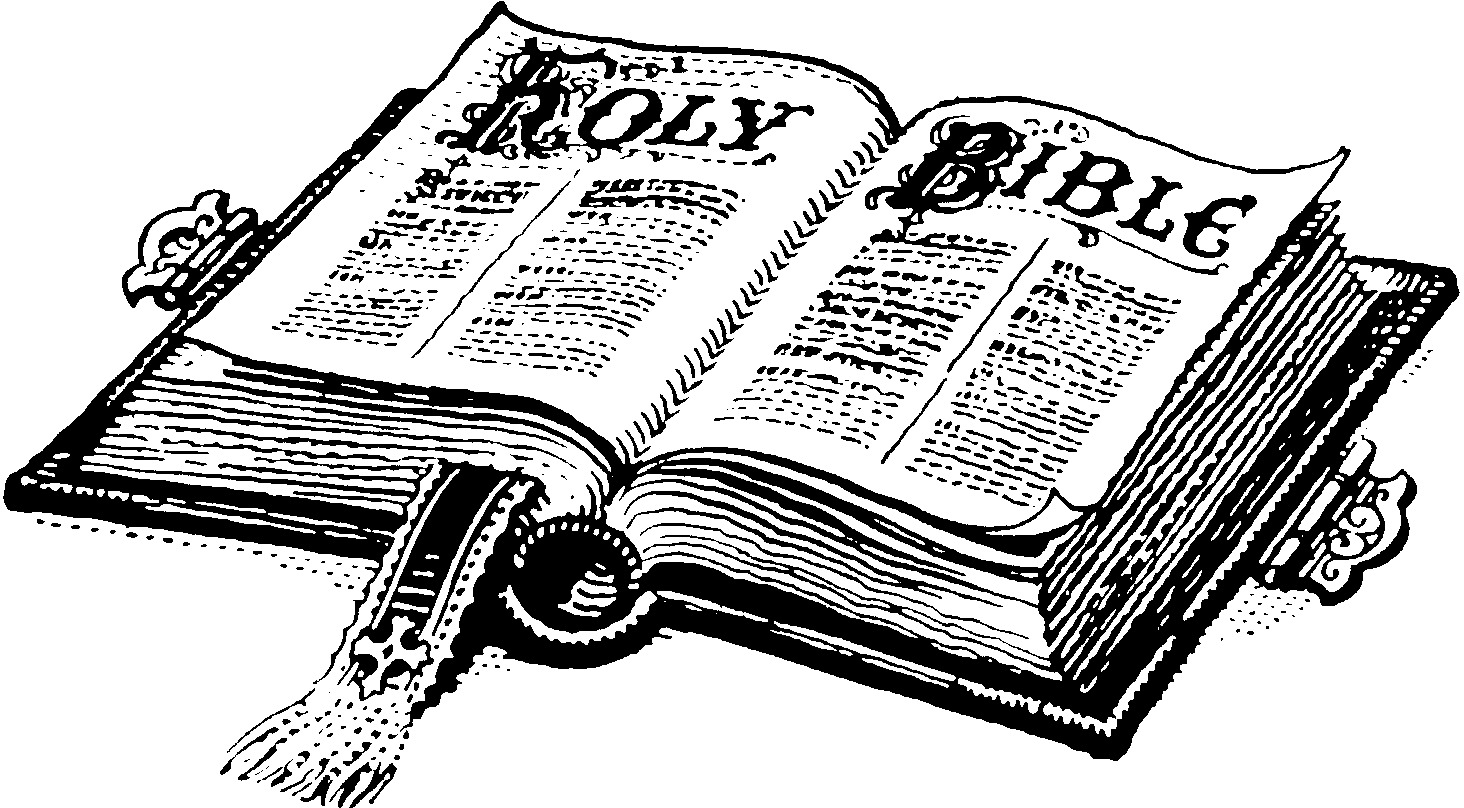
di Letizia Tesi
Presepio o albero di Natale? Oggi l'uno non esclude l'altro, ma un tempo non era così. C'è stato un periodo in cui era considerato quasi un sacrilegio che il bue e l'asinello vegliassero il divin bambino al riflesso artificiale di luci intermittenti anziché al chiarore astrale della cometa. La contrapposizione fra queste due pratiche natalizie era vista allora contrapposizione fra due polarità, sacro e profano. Le statuine di gesso del presepio narrano da sempre la storia di Betlemme con un linguaggio semplice ed efficace, che rispecchia l'immaginario collettivo, senza nulla togliere alla sacralità dell'evento.
L'albero di Natale, invece, era considerato all'inizio un usurpatore dello spazio sacro, imposto dalla forza di penetrazione di modelli prima del Nord Europa e poi americani. L'ingresso di queste usanze nell'ambito domestico, comunque, è storia piuttosto recente. Anche il presepio, infatti, prima di entrare nelle case, lo si andava a vedere nelle chiese e nei conventi. Tra le mura domestiche, il 25 dicembre si festeggiava con tradizioni che potevano variare anche da luogo a luogo. Un dato è certo, tradizioni a parte: il Natale è contraddistinto, da sempre, come una festa dell'abbondanza, uno dei giorni dell'anno in cui concedersi quello che non si può permettere quotidianamente. Anche se la parola “consumismo” non esisteva, la ricorrenza del Natale veniva salutata con un impiego di beni superiore al normale. I preziosi animali da cortile, una volta tanto, finivano sulla tavola. Se oggi il segno universale del Natale è il panettone, anche se in decine di varianti, cinquant'anni fa i piatti erano più variegati. A Pescia, la sera della vigilia, usava fare una cena di magro a base di broccoli, baccalà e castagne secche. Anche a Tizzana si festeggiava con castagne secche cotte nell'acqua e baccalà per companatico. Per un menu completo prendiamo quello che era in uso a Prato. Accanto ai consueti crostini di fegato, l'antipasto prendeva il collo ripieno del pollo lessato, fatto a fette.

Di primo, invece, si mangiava pasta fatta in casa, tagliata a striscioline e servita nel brodo grasso ricavato dal lesso, dalla gallina e dai colli di pollo. Si continuava con arrosto misto di tacchino, pollo e patate, cotti a legna nelle cucine economiche e conditi con l'olio ”buono” delle colline. Sulla tavola anche una bottiglia di vino Carmignano e per finire i “cantucci di Mattonella”, affinati col vinsanto. Oggi i famosi biscotti di Prato, esportati dappertutto, si mangiano tutto l'anno, ma prima erano considerati un lusso. A Tizzana e a Calamecca la sera della vigilia, dopo la messa si giocava a semolino. Ogni partecipante nascondeva un soldo dentro un mucchio di semola steso sul tavolo. Dopo aver ben rimescolato la semola, si facevano tanti monticelli quanti erano i partecipanti. Così, alla fine, ognuno aveva un monticello nel quale “frugare” e recuperare i soldi nascosti. Gli abitanti del Nespolo andavano a messa con delle lanternine rosse. Una volta in chiesa la bimba, che durante l'anno era stata più brava a catechismo, veniva fatta salire sui gradini dell'altare a recitare un discorso che le aveva insegnato il priore. Ma la tradizione che lega insieme Pistoia e Prato è quella del ceppo. In origine il ceppo era un pezzo di legno scavato internamente per deporvi le offerte. Oggi sta prevalentemente ad indicare un dono da farsi durante le feste natalizie, ma per molto tempo ha avuto un'altra funzione. Nella campagna, dopo la messa di mezzanotte, si metteva un grosso pezzo di legno sul fuoco, il ceppo appunto, perché nella notte Gesù bambino ci si potesse riscaldare. Al Nespolo e alla Ferruccia, ma anche in altri paesi, invece, il ceppo si metteva sul fuoco prima della cena di vigilia, ma non si faceva consumare fino in fondo. La tradizione del Nespolo imponeva che il ceppo bruciasse un po' per volta fino al giorno di Befana. Il 6 Gennaio i bambini sostituivano il ceppo bruciato con un panierino di fieno per il “ciuchino” della Befana. Alla Ferruccia, invece, il ceppo si andava a spegnere nella stalla dove si conservava fino alla vigilia dell'anno successivo in segno di benedizione. La tradizione del ceppo è talmente radicata da essere entrata anche nel lessico popolare. Per esempio a Prato si dice “Tu l'avrai tre messe a ceppo” per indicare che si dovrà aspettare a lungo e magari invano per aver qualcosa in abbondanza o per conseguire un risultato soddisfacente. Il detto fa riferimento proprio ad una consuetudine natalizia.

Il 25 dicembre infatti, ai sacerdoti era concesso di trattenere interamente le offerte raccolte durante le tre messe che in quel giorno potevano celebrare, senza doverne versare una parte alla Curia. Il ceppo compare anche in un altro modo di dire, ancora più colorito: “Camperò fin a Ceppo”. E' un'espressione scaramantica per indicare uno stato di salute non ottimale. Altra tradizione che unisce Prato e Pistoia è quella di accendere dei fuochi la notte di Natale. I pratesi accendevano falò sui monti, ai crocicchi delle strade ed anche in città, davanti ai tabernacoli. A Frassignoni il fuoco della notte di Natale si chiamava “dovizia”. I bambini facevano a gara a raccogliere la legna già un mese prima della vigilia perché il loro fuoco fosse più bello e più grande di quello degli altri. I falò si accendevano appena suonata l'Ave Maria della sera e tutti vi si riunivano intorno per cantare la pastorella “Tu scendi dalle stelle”. Il divertimento maggiore dei ragazzi più grandi era quello di andare in giro con un pezzo di castagno acceso, preparato prima perché fosse ben secco. Tutt'intorno, da un casolare, all'altro, risuonavano colpi di fucile e di mortaretto. Quando il fuoco era sul punto di spegnersi ciascun capo famiglia prendeva un tizzo e lo portava nella stalla perché le bestie si mantenessero sane e redditizie. E oggi? Non ci sono certo più le vecchie usanze, ma senza che ce ne rendiamo conto, stanno prendendo campo altre tradizioni. Anche il vecchio abete forse verrà presto sostituito da altre piante, meno “natalizie”, ma più adatte ad essere ripiantate dopo che hanno abbellito le case con le palle colorate. Chi vuol essere “ecologicamente corretto” lasci pertanto l'abete in montagna.
Un sentito grazie alla giornalista Letizia Tesi, la quale ci ha concesso di pubblicare questo articolo.